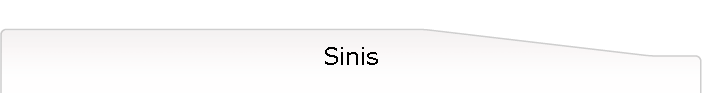|
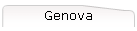

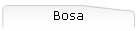
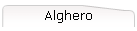
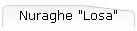
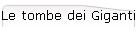
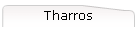

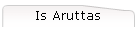
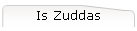

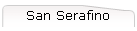
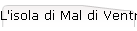
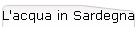
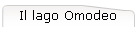
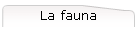
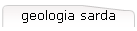

| |
La penisola del Sinis è un’area che si estende nella provincia di Oristano.
La zona è caratterizzata da spiccate qualità paesaggistiche e da singolari
valori naturalistici ed ambientali grazie alla piu ampia presenza di stagni di
tutta la Sardegna. A queste bellezze paesaggistiche va aggiunta la grande
importanza archeologica rappresentata dagli scavi archeologici dell’antica
Tharros e
dell’ipogeo di San Salvatore. La necessità di proteggere questo territorio dal
disordine edilizio e dalle alterazioni ecologiche è alla base della recente
iniziativa di “Italia Nostra” di inserire l’area intera del Sinis con la
fronteggiante isola di
Mal di Ventre e il braccio di mare tra le rispettive coste nel
programma di “Proposte per un sistema di Parchi e riserve naturali in Sardegna”.
Da qualche anno vi è stata istituita un’Area Marina Protetta, che tra gli altri
meriti ha quello di iniziare a spiegare ai visitatori le tante, notevoli valenze
di tipo geologico.
Il paesaggio geologico della penisola del Sinis appare unico in Italia: lungo il
mare imponenti falesie si alternano ad eccezionali, candide spiagge di granuli
di quarzo; in alcuni punti della costa vi sono cave storiche di arenaria.
All’interno, ad est c’è la enorme distesa d’acqua dello Stagno di Cabras, verso
nord la depressione salina, bianca e piatta di Sale Porcus, un ambiente spesso
desertico, che, assieme alle eccezionali grandi dune di Is Arenas ubicate poco
più a nord, formano un paesaggio spesso inviolato.
Nel mare prospiciente vi sono due piccole isole disabitate geologicamente del
tutto diverse, una di granito (Mal di Ventre) ed una di basalto (Il Catalano).
La storia geologica del Sinis e dell’isola di Mal di Ventre, ha inizio nel
Paleozoico, circa 300 milioni di ani fa, con la messa in posto dell’imponente
basamento di granito che va dalla Sardegna alla Corsica.
Infatti l’isola di Mal di Ventre è interamente costituita da tale granito e
possiede quindi una tale “vecchia” età: nel Sinis non affiorano altri graniti ma
si ritiene che l’antico basamento stia in profondità, al di sotto delle altre
rocce più recenti.
Tornando alle rocce del Sinis, in questo territorio non ve ne sono di
appartenenti all’era mesozoica: dal granito paleozoico di Mal di Ventre si
arriva direttamente ai calcari ed alle vulcaniti dell’era cenozoica, rocce
peraltro molto diffuse in Sardegna. Le rocce vulcaniche sono tipiche andesiti,
lave compatte e di colore grigio.
Altre lave nere, di basalto, verranno fuori nel Pliocene da grandi fratture con
direzione N-S: un esempio tipico sono i grandi massi arrotondati neri come la
pece che costituiscono gli scogli alle falde della Torre di S. Giovanni di Sinis
e nei pressi dell’importante sito archeologico di
Tharros.
Dove non sono fuoriuscite lave basaltiche plioceniche, sopra ai calcari
miocenici, estesamente diffusi, affiorano strati di arenarie anch’esse di età
pliocenica. I granuli di tali arenarie sono di composizione calcarea e risultano
quindi l’evidente prodotto dello smantellamento in mare dei calcari miocenici
preesistenti.
Successivamente, sempre durante il Pliocene, l’intera Penisola del Sinis emerse
dal mare, non si depositarono più strati di calcari, ricchi di fossili tipici
marini, bensì si formarono in ambiente costiero di terraferma grandi dune di
sabbia, di origine eolica. Il promontorio di S. Giovanni di Sinis - Capo S.
Marco, certamente originato dai neri basalti plio-quaternari fuoriusciti dalla
grande frattura prima descritta, che ha per l’appunto la direzione nord-sud del
promontorio: proprio in questo caso risulta ancora più evidente come il
paesaggio di oggi dipende dagli eventi geologici di ieri.
Sulla riva orientale del promontorio sorge l’antica e preziosa città
fenico-punica-romana di
Tharros: da notare che il cardo maximus, il viale
principale della città, è interamente lastricato di tavole di basalto,
certamente cavato e lavorato nelle vicinanze.
Ad est i piccoli rilievi del promontorio degradano dolcemente verso le grandi
lagune (in Sardegna chiamati “stagni”) di Cabras e di Mistras, importanti anche
sotto il profilo geomorfologico e paesaggistico, a parte i ben noti aspetti
naturalistici e dell’attività della pesca.
L’origine di queste importanti zone umide comunicanti con il mare, elementi
fondamentali della storia e della vita di oggi nel Sinis, risulta più antica di
quanto uno possa immaginarsi. Infatti il continuo altalenarsi degli eventi di
ingressione e regressione delle acque marine, assieme alle variazioni continue
degli apporti solidi dei corsi d’acqua che arrivano dall’entroterra, originarono
la formazione di stagni e lagune già durante il Messiniano, un periodo del
Miocene caratterizzato dal progressivo abbassamento del livello marino, con
particolare salinità.
Per quanto riguarda la flora e la fauna, c’è da osservare che la vegetazione si
presenta variabile in relazione alla diversa conformazione della costa mentre
gli stagni costieri, a carattere permanente o temporaneo, costituiscono un
ulteriore tipo di unità ambientale, mentre la fauna, soprattutto per quanto
riguarda l’avifauna nidificante, ben 15 si riproducono nella Penisola del Sinis
o nelle isole prospicienti, mentre di altre 7 specie appare probabile la
nidificazione. Tra le nidificanti segnalate spiccano il falco di palude l’albanella
minore, il falco pellegrino e il gabbiano corso.
|