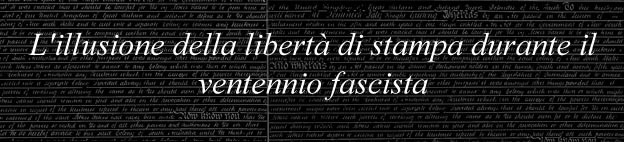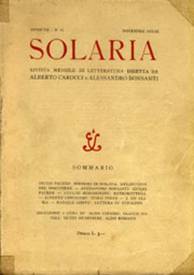|
|
|
La politica culturale del regime fascista, fu
relativamente tollerante e lungimirante (a differenza, per esempio, del
nazismo, che del mondo intellettuale fece terra bruciata). Le ragioni di
questa politica si possono oggi individuare con sufficiente chiarezza: in
primo luogo, Mussolini era ben consapevole del livello d’arretratezza
culturale in cui versava la maggioranza del popolo italiano, ed era quindi
cosciente della scarsa risonanza che avevano, a livello di massa, critiche e
polemiche espresse su riviste che andavano in mano a poche migliaia di
persone. Infatti, il quotidiano “Solaria”, per esempio, non superò mai le
tremila copie. Era dunque nell’interesse del potere permettere, entro certi
limiti, forme di dissenso che da un lato davano l’illusione della libertà,
mentre dall’altro risultavano sostanzialmente innocue. È chiaro d’altronde
che, quando certi limiti venivano superati, allora (si vedano i casi di
Godetti e dei fratelli Rosselli) la repressione scattava dura e puntuale.
Tuttavia, finché rispettavano le regole, agli intellettuali veniva
riconosciuta una certa autonomia: è così, per esempio, che a Benedetto
Croce, redattore e firmatario del Manifesto degli intellettuali
antifascisti, fu consentito di pubblicare durante tutto il ventennio la sua
rivista “La critica”. Così come a Croce anche ad altri giovani scrittori
notoriamente critici verso il regime, come Vasco Pratolini, Romano Bilenchi,
Alfonso Gatto, Elio Vittorini, fu permesso di scrivere sulle principali
riviste di cultura, (notevole è l’esperienza di “Primato”, la rivista
diretta dal gerarca Giuseppe Bottai, che apri le sue pagine ai più
combattivi esponenti del dissenso). "ORA LA STAMPA E' LIBERA!" |