|
|
||||||||
|
Il cielo è stato a lungo considerato come immutabile, e i fenomeni che avvengono sulla volta celeste, ripetendosi con grande regolarità, hanno permesso di stabilire alcune delle principali unità di tempo:il giorno, il mese e l’anno. Ogni deviazione dal “normale” comportamento degli astri incute quindi un certo timore; tale sensazione è ancora più forte se qualche cosa di nuovo appare in cielo, o se astri conosciuti scompaiono alla vista. Tutti sappiamo, e anche le popolazioni antiche se ne rendevano conto, che la vita dipende strettamente dalla luce e dal calore del Sole; la scomparsa improvvisa della stella del giorno è quanto di più temibile l’umanità possa immaginare. Non deve stupire, quindi, che le eclissi di Sole rappresentassero anticamente un evento terribile. Fu solo con lo studio sistematico dei fenomeni astronomici che, i Babilonesi, per primi, scoprirono la natura illusoria delle eclissi. Infatti la sparizione dell’astro è semplicemente dovuta all’interposizione di un altro oggetto lungo la linea di visuale. Per centinaia di anni i Babilonesi, Cinesi, Arabi, Maya e Egizi nonché Europei concentrarono la loro attenzione in particolare sulla Luna e sul Sole. Alcune tavolette d’argilla, portate alla luce negli scavi dell’antica città di Babilonia, documentano per prime le eclissi di Sole e di Luna, risalenti rispettivamente al 21 marzo 154 a.C. e 19 marzo del 721 a.C., le prime trascritte.
La Terra e la Luna sono considerate “corpi
opachi di forma sferica”, pertanto essi vengono illuminati soltanto
sull’emisfero rivolto verso il Sole mentre dalla parte opposta inviano nello
spazio dei coni d’ombra. Poiché l’orbita della Luna giace su un piano
inclinato di 5° 19’ rispetto a quello della Terra, le eclissi non avvengono
ogni mese, ma solo quando la Luna interseca l’eclittica, ossia il piano
dell’orbita terrestre, nei cosiddetti nodi e contemporaneamente si trova
allineata con la Terra e il Sole.
Le eclissi solari:
avvengono quando la Luna, in fase di novilunio, si trova tra il Sole e la
Terra e proietta il suo cono d’ombra su alcune zone della superficie
terrestre, dalle quali risulta pertanto impossibile vedere il Sole. Poco
prima che l’eclisse sia totale la piccola falce solare percettibile lungo il
bordo della Luna si trasforma in minute perle scintillanti dette “grani di
Baily”. Questi durano solo pochi secondi, allo sparire del Sole e possibile
osservare il cosiddetto “anello di diamante” (un anello infuocato attorno
alla Luna formato dalla parte interna della corona solare), e infine, quando
il Sole è coperto, la corona solare.
Le eclissi di Sole possono essere:
Le eclissi totali si verificano quando il Sole viene nascosto completamente dalla Luna, in fase di novilunio e in uno dei due nodi; però interessano zone piuttosto ristrette della superficie terrestre. Queste stesse eclissi sono osservabili come parziali da tutti i luoghi della Terra che vengono investiti dalla penombra. Inoltre, tra le eclissi di Sole, presentano un interesse particolare quelle anulari, le quali si verificano, sempre in novilunio, quando la Luna si trova in uno dei nodi e contemporaneamente sta alla sua massima distanza dalla Terra, ossia nell’apogeo. In queste condizioni il cono d’ombra della Luna non giunge a toccare la superficie terrestre e quindi essa non riesce ad occultare completamente il disco solare, del quale così si può vedere la parte periferica a forma di anello luminoso.
Le eclissi lunari: si verificano quando
la Luna, in fase di plenilunio (ossia quando Sole, Terra e Luna sono
perfettamente allineati) ed in vicinanza o in uno dei nodi, passa nel cono
d’ombra della Terra e di conseguenza ne risulta oscurata. Questo tipo di
eclissi possono essere sia totali che parziali.
Nel primo caso la Luna passa completamente dentro il cono d’ombra della Terra, il quale si presenta notevolmente ampio rispetto alle dimensioni della Luna. Nel secondo caso, invece, solo una parte del satellite passa nell’ombra o anche solo nella penombra proiettata dalla Terra. L’eclisse di Luna, quando si verifica, è visibile da tutte le zone del nostro pianeta in cui il satellite si trovi sopra l’orizzonte.
Il ciclo Saros Altre eclissi Mito e simbolismo delle eclissi Alcune eclissi storiche 26 febbraio 1504 18 luglio 1860 29 maggio 1919 |


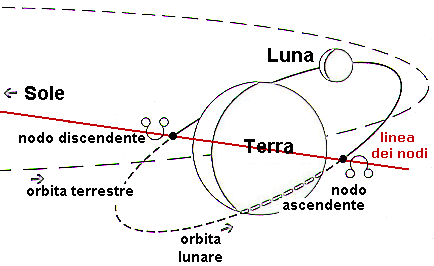






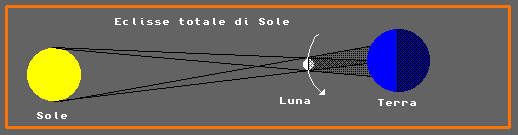
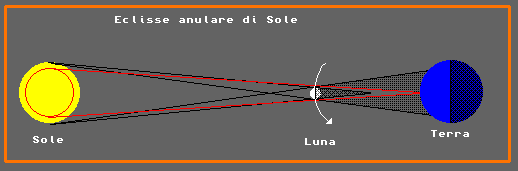


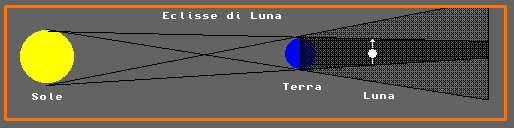
 Allora
Colombo, avendo a bordo un calendario delle eclissi lunari, escogitò un
piano per ingannarli. La sera in cui si sarebbe verificata l’eclisse
organizzò un incontro con i capi delle popolazioni indigene e disse loro che
Dio era molto offeso e che avrebbe fatto sparire la Luna. Come previsto, un
ombra scura iniziò a oscurare il disco lunare e gli indigeni, spaventati,
dissero a Colombo che gli avrebbero fornito il cibo se avesse calmato Dio.
Questo, dopo essersi ritirato a “conferire” con la divinità, ritornò poco
prima della fine dell’eclisse e disse loro che Dio li aveva perdonati. La
Luna ritornò a splendere e Colombo ottenne le scorte di cibo.
Allora
Colombo, avendo a bordo un calendario delle eclissi lunari, escogitò un
piano per ingannarli. La sera in cui si sarebbe verificata l’eclisse
organizzò un incontro con i capi delle popolazioni indigene e disse loro che
Dio era molto offeso e che avrebbe fatto sparire la Luna. Come previsto, un
ombra scura iniziò a oscurare il disco lunare e gli indigeni, spaventati,
dissero a Colombo che gli avrebbero fornito il cibo se avesse calmato Dio.
Questo, dopo essersi ritirato a “conferire” con la divinità, ritornò poco
prima della fine dell’eclisse e disse loro che Dio li aveva perdonati. La
Luna ritornò a splendere e Colombo ottenne le scorte di cibo.