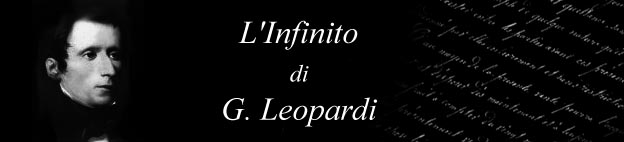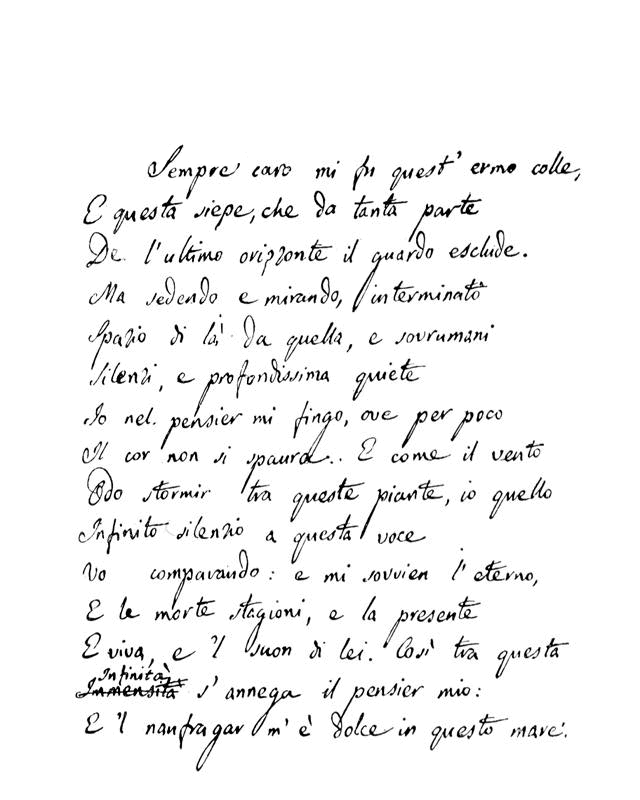|
Nasce a Recanati il 29 giugno 1798 dal conte
Monaldo e da Adelaide dei marchesi Antici. Fu un autodidatta e nella
biblioteca del padre si diete ad uno studio "matto e disperatissimo"; lo
sforzo notevole debilitò il suo fisico già minato e a 18 anni fu in pericolo
di morte. Il suo primo carme è significativo nel titolo Appressamento della
morte. Gli fu allora molto vicino l'amico Pietro Giordani, che lo introdusse
negli ambienti culturali. L’Infinito Idillio, in greco, significa "piccolo quadro", "immagine" e tradizionalmente rappresentava, piccole scene campestri, spesso di vita pastorale, e aveva come scopo quello di valorizzare il contatto con la natura. In realtà i componimenti leopardiani hanno poco in comune con l’idillio di Teocrito o di Mosco, e ancor meno con la tradizione settecentesca dell’idillio in volgare. In questo caso, infatti, pur partendo sempre da un'esperienza di natura, l'idillio esprime gli stati d'animo più profondi del poeta, e la descrizione della natura è solo occasione per parlare di sé. Il luogo della riflessione del poeta è il monte Tabor di Recanati, ma nella lirica esso appare lontano dalla realtà, in un mondo di fantasia, il luogo appartato ci suggerisce, però, la solitudine del poeta ed il suo isolamento. La siepe rappresenta l’impedimento, la forza che pone dei limiti invalicabili alla conoscenza dell’uomo, ma è gradita al poeta perché gli permette di spaziare con la fantasia e di crearsi illusioni. Leopardi, infatti, si costruisce col pensiero spazi interminabili, che si estendono al di là dalla siepe e li riempie di un silenzio sovrumano. Il suo animo, supera i limiti della sua individualità e si perde, smarrito, nell’infinità. Il vento che passa fra le foglie e le fa stormire rappresenta un lieve sussurro se paragonato all’immaginato sovrumano silenzio. Le età ormai scomparse (le morte stagioni) sono state un momentaneo bisbigliare di foglie mosse dal vento e di loro non è rimasta alcuna traccia. Avverrà così anche per l’epoca presente, la quale, oggi, è viva per un attimo prima di smarrirsi e scomparire nell’immensità del tempo. Questo smarrirsi nell’immensità dell’infinito è come un naufragare in un mare aperto, soltanto in questo modo l’animo del poeta trova la sua quiete in questo immergersi nell’infinito. CommentoQuest’idillio non può essere stato suggerito da un'ispirazione improvvisa o da una percezione istintiva della natura. Qui ogni parola è incredibilmente pesata e studiata. Sempre caro mi fu
quest'ermo colle, Il colle e la siepe sono cari al poeta perché impediscono la vista, spingendolo ad immaginare; c'è quindi un rapporto causa-effetto tra "caro" ed "esclude" (è "caro" perché "esclude"). L'uomo, non vedendo con gli occhi, è invitato a vedere con la mente. Nello Zibaldone Leopardi annota infatti: "L'anima immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario". La siepe può essere paragonata al velo Maya di Shopenhauer, infatti, entrambi, creano una sorta d’illusione che impedisce di vedere la realtà così com’è effettivamente. Ma sedendo e
mirando, interminati Si noti che nel testo originario non si parla di "interminati spazi" come nella versione definitiva ma di "interminato spazio”. Ai versi 4 e 5 c'è continuità semantica tra "interminati" e "sovrumani" e tra "spazi" e "silenzi". Inoltre "interminati", "sovrumani" e "profondissima" suggeriscono l'infinità di spazio in cui si muove la fantasia del poeta.Tale è la grandezza degli spazi che il cuore sobbalza: "per poco il cor non si spaura". Mente e cuore, abituati a vivere nel finito, quasi si smarriscono nell'infinito. “Mi fingo”: per spiegare l’uso di questo termine è significativo riportare una frase di Ungaretti (da Secondo discorso su Leopardi): “fingo è una parola usata nel senso dotto per indicare mi foggio, mi formo […] ossia io nel pensiero mi suscito interinati spazi, sovrumani silenzi, per inganno, per illusione […]. Quando erano giovani i tempi, quando si diceva “fingere” alla latina, le illusioni si “foggiavano”. Il punto a metà del verso 8 divide perfettamente in due momenti l’idillio, uno visivo e poi uno uditivo,uniti da "E". Si crea così una corrispondenza perfetta tra le due parti della poesia e tra le due fasi dell'esperienza. E come il vento Il poeta qui s’immagina l’eterno, le età passate e il rumore dell’età presenta il quale viene paragonato al silenzio delle epoche morte; allo stesso modo lo stormire del vento veniva paragonato ai sovrumani silenzi immaginati al di là della siepe. Così tra questa L’indicativo “questa” usato in relazione a
“immensità” segna il definitivo rinchiudersi del poeta nel mondo delle sue
immaginazioni e delle sue illusioni, con un totale estraniamento dalla
realtà circostante. Il naufragio, lo smarrimento, è "dolce", termine che
rimanda al "caro" del v. 1. La poesia è ricca dei dimostrativi “questo” e “quello”. Il primo delinea il tangibile, ossia il finito, il secondo il remoto, ossia l’infinito. |
|
|