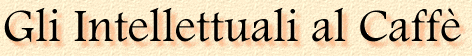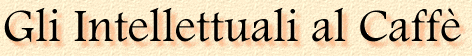|
Una delle innumerevoli,
profonde e vibranti poesie che compongono il Canzoniere di Umberto Saba, è
dedicata a un Caffè, il Caffè Tergeste.
Caffè Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi
ripete l'ubbriaco il suo delirio;
ed io ci scrivo i miei più allegri canti.
Caffè di ladri, di baldracche covo,
io soffersi ai tuoi tavoli il martirio,
lo soffersi a formarmi un cuore nuovo.
Pensavo: Quando bene avrò goduto
la morte, il nulla che in lei mi predico,
che mi ripagherà d'esser vissuto?
Di vantarmi magnanimo non oso;
ma, se il nascere è un fallo, io al mio nemico
sarei, per maggior colpa, più pietoso.
Caffè di plebe, dove un dì celavo
la mia faccia, con gioia oggi ti guardo.
E tu concili l'italo e lo slavo,
a tarda notte, lungo il tuo biliardo.
(da La serena
disperazione 1913-1915,
ora in Antologia del Canzoniere, Torino, Einaudi, 1987, p.61)
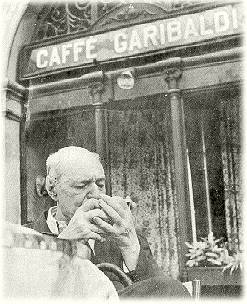 Sono
versi che esprimono lo stupore di un poeta dinanzi alla realtà quotidiana fatta di gente
comune che sconta, tutti i giorni, la fatica di vivere. Sono ladri e puttane, sono
italiani e slavi, sono persone tanto distanti dall'uomo Umberto, ma così vicine al poeta
Saba. Il Caffè Tergeste rappresenta l'opposto di quello che era, allora, il
luogo prediletto dagli intellettuali, il Caffè Garibaldi: "Quel tavolo del
Caffè Garibaldi [a Trieste], sotto il municipio, tra le sette e le nove di sera degli
anni che seguirono all'altra guerra - scrive Giani Stuparich (cfr. Al Caffè con
Stuparich in Enrico Falqui, Caffè letterari, Roma, Canesi, 1962) pensando
al fratello Carlo e all'amico Scipio Slataper che dalla guerra non erano tornati - è
passato alla storia. Trieste non ebbe forse mai un affiatamento di spiriti così
vasto." Sono
versi che esprimono lo stupore di un poeta dinanzi alla realtà quotidiana fatta di gente
comune che sconta, tutti i giorni, la fatica di vivere. Sono ladri e puttane, sono
italiani e slavi, sono persone tanto distanti dall'uomo Umberto, ma così vicine al poeta
Saba. Il Caffè Tergeste rappresenta l'opposto di quello che era, allora, il
luogo prediletto dagli intellettuali, il Caffè Garibaldi: "Quel tavolo del
Caffè Garibaldi [a Trieste], sotto il municipio, tra le sette e le nove di sera degli
anni che seguirono all'altra guerra - scrive Giani Stuparich (cfr. Al Caffè con
Stuparich in Enrico Falqui, Caffè letterari, Roma, Canesi, 1962) pensando
al fratello Carlo e all'amico Scipio Slataper che dalla guerra non erano tornati - è
passato alla storia. Trieste non ebbe forse mai un affiatamento di spiriti così
vasto."
Stuparich fa una suggestiva carrellata dei clienti abituali del Garibaldi fra i quali
spiccani i nomi di Julius Kugy, definito spirito europeo, e di James Joyce, uno spirito
universale. Accanto a questi illustri stranier non mancavano certo gli italiani, anzi
i triestini: primo fra tutti Italo Svevo che "sapeva fondere con la sua animata e
spiritosa socievolezza - spiega Stuparich - la compagnia del Caffè Garibaldi.
[...] Svevo sapeva conquistare persino Saba: ed era, specie in quegli anni, non
facile impresa. Saba s'iniziava allora al freudismo, con tutti gli alti e bassi di una
nevrastenia scontrosa e patita, che solo più tardi doveva trovare nei "misteri
freudiani" il suo centro di sollievo. Svevo, in certo qual modo aveva già disciolto
il freudismo nell'ironia, nella sua ironia."
Faceva parte della comitiva anche il poeta Virgilio
Giotti che aveva con Saba un rapporto "più delicato e pericolante" anche se
più intenso di quello con Svevo. "I due poeti - scrive ancora Stuparich - si
sentivano paralleli, ma non evitavano certi cozzi a cui li portava il loro carattere
diverso. Da Giotti ho sentito più volte - ammette Stuparich - esprimere un giudizio sulla
poesia di Saba, da Saba su Giotti mai."
Molto forte era pure l'amicizia tra Giani Stuparich e Giotti che, una volta sciolta la
compagnia del Caffè Garibaldi, durante i difficili mesi dell'occupazione
tedesca, continuarono a incontrars iin "quel piccolo bar popolare di via Ginnastica,
ch'egli ha fissato - scrive Stuparich - vivo per sempre nei colori della sua poesia."
Questo gruppo di amici, gli assidui del Caffè Garibaldi, erano così
legati al locale che, quando venne chiuso fecero secesione e si spostarono in
massa al vicino Bar Nazionale.
Alla compagnia si aggiunsero presto alcuni amici occasionali come il mtematico e musicista
Guido Voghera, Silvio Pittoni, fratello del deputato socialista, il pittore klimtiano
Timmel e Roberto, Bobi Bazlen, per citarne soltanto alcuni.
Passavano gli anni e il gruppo si assottigliava
inesorabilmente: "Erano scomparsi Svevo e Bolaffio. Saba s'era ritirato e bisognava
andarlo a cercare nella sua bottega d'antiquario o a casa sua, dove non era raro
incontrarvi Giovanni Comisso e, più tardi, Sandro Penna." Della vecchia compagnia
restavano soltanto Stuparich, Giotti e il pittore Schiffrer che si erano spostati al
vecchio Caffè delle Stazione e fu a quel punto che si aggiunse Pierantonio
Quarantotti Gambini.
Scrive Quarantotti Gambini (cfr. Al Caffè con Quarantotti Gambini inEnrico
Falqui, Caffè letterari, Roma, Canesi, 1962) : "ancora ragazzetto,
intorno al 1924-25, ogni qual volta mi avveniva di passare di sera davanti ai cristalli
del Caffè Garibaldi, non riuscivo a fare a meno di gettare un'occhiata nell'ultima
saletta, a destra, dove, sotto il grande e bel ritratto di Garibaldi in piedi e in camicia
rossa, vedevo radunati alcuni signori." Lo scrittore triestino allarga il quadro
degli incontri al Caffè ricordando anche i momenti allo Stella Polare dove
Virgilio Giotti gli disse che alcuni anni prima si era fermto anche James Joyce "cosa
che mi sembra molto probabile - commenta Quarantotti Gambini - dato che questo Caffè era
il più prossimo alla Berlitz School, presso la quale egli insegnava."
Se il Caffè Stella
Polare era tappa obbligata durante l'inverno, d'estate i letterati preferivano
darsi appuntamento al Caffè Nazionale; si era unita al gruppo anche Delia Benco, moglie
di Silvio Benco, autore di una suggestiva guida su Trieste (1910) che era però
una personalità di rilievo all'interno di un altro gruppo di giornalisti e studiosi. Al
gruppo di Quarantotti Gambini mancava soltanto Saba, sempre più schivo, sempre più
freuidiano. Una notazione interessante di Quarantotti Gambini riguarda la presenza a
Trieste del grande scrittore francese Stendhal. Quarantotti Gambini si chiede in quale
Caffè potesse essersi fermato Henri Beyle, console di Francia a Trieste tra il 1830 e il
1831 e ritiene che l'unica risposta possibile fosse al Caffè
Tommaseo, allora il principale Caffè della città.
OGGI "Il caffè è l'unico luogo
in cui si può veramente scrivere: si è soli, con carta e penna e tutt'al più i due o
tre libri di cui si ha bisogno in quel momento - spiega Claudio Magris in I luoghi del
disincanto, Trieste 1987 - abbandonati a se stessi e costretti a far contosoltanto su
se stessi, a raccogliere le proprie energie e dosarle con misura; il tavolino su cui si
poggia il foglio diviene la tavoladi un naufrago, cui ci si aggrappa, mentre la familiare
armonia che ci circonda si svuota, diviene l'incerta cavità del mondo, nel quale la
scrittura si addentra, perplessa e ostinata."
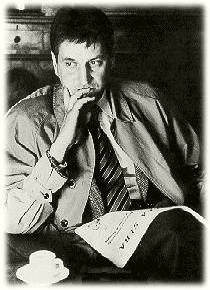 Sono parole
scritte pensando al Caffè Tommaseo (dopo la ristrutturazione dell'edificio che
lo ospita, compiuta fra il 1984 e il 1986 dalle Generali) ma sedendo a un tavolino del Caffè San Marco, il preferito da Magris che gli
dedica il primo capitolo dei suoi Microcosmi (Milano, Garzanti, 1997). "Il
San Marco è un vero Caffè, periferia della storia contrassegnata dalla fedeltà
conservatrice e dal pluralismo liberale dei suoi frequentatori. [...] Al San Marco Trionfa
- osserva Magris - vitale e sanguigna, la varietà." Magris pensa al Caffè
come a un luogo del disincanto dove si ripete immutato e al tempo stesso sempre
nuovo uno spettacolo già visto in cui ognuno riesce forse a ritrovare se stesso. Anche
Magris, come Stuparich, ricorda i tanti nomi di intellettuali che si sono fermati a
dicutere, a scrivere, a vivere qualche ora in questo Caffè: fra i tanti nomi spicca
quello di Giorgio Voghera (figlio di Guido) che ricordiamo per gli studi sull'ebraismo e
sulla psicanalisi. Sono parole
scritte pensando al Caffè Tommaseo (dopo la ristrutturazione dell'edificio che
lo ospita, compiuta fra il 1984 e il 1986 dalle Generali) ma sedendo a un tavolino del Caffè San Marco, il preferito da Magris che gli
dedica il primo capitolo dei suoi Microcosmi (Milano, Garzanti, 1997). "Il
San Marco è un vero Caffè, periferia della storia contrassegnata dalla fedeltà
conservatrice e dal pluralismo liberale dei suoi frequentatori. [...] Al San Marco Trionfa
- osserva Magris - vitale e sanguigna, la varietà." Magris pensa al Caffè
come a un luogo del disincanto dove si ripete immutato e al tempo stesso sempre
nuovo uno spettacolo già visto in cui ognuno riesce forse a ritrovare se stesso. Anche
Magris, come Stuparich, ricorda i tanti nomi di intellettuali che si sono fermati a
dicutere, a scrivere, a vivere qualche ora in questo Caffè: fra i tanti nomi spicca
quello di Giorgio Voghera (figlio di Guido) che ricordiamo per gli studi sull'ebraismo e
sulla psicanalisi.
Fra i nomi noti Magris accenna anche agli sconosciuti, alle persone di passaggio, ai
giovani studenti e agli appassionati scacchisti che costituiscono, tutti insieme nella
loro affascinante molteplicità, la compagnia del Caffè San Marco.
Se da qui ci si sposta sulle rive, non è difficile trovare seduto ai tavolini del Caffè
Tommaseo lo scrittore Fulvio Tomizza. |